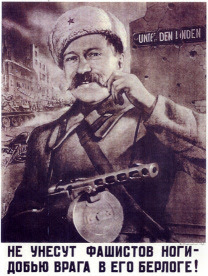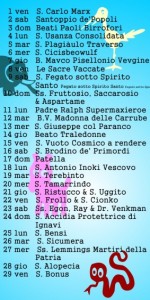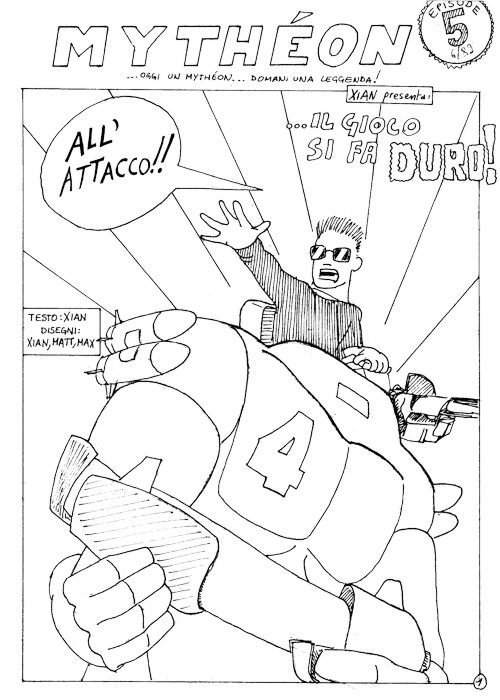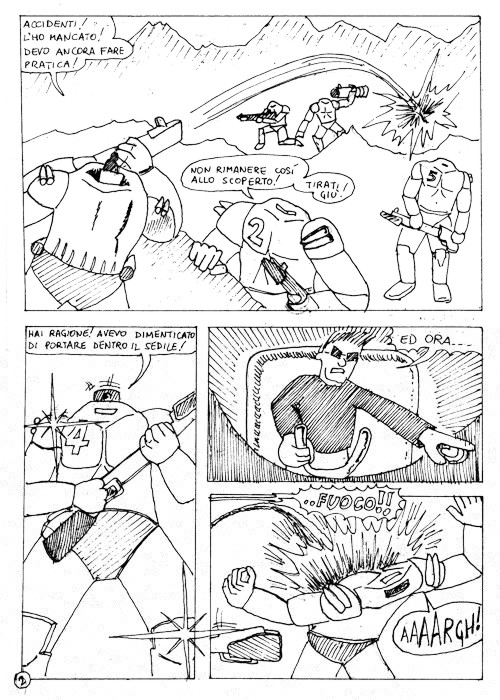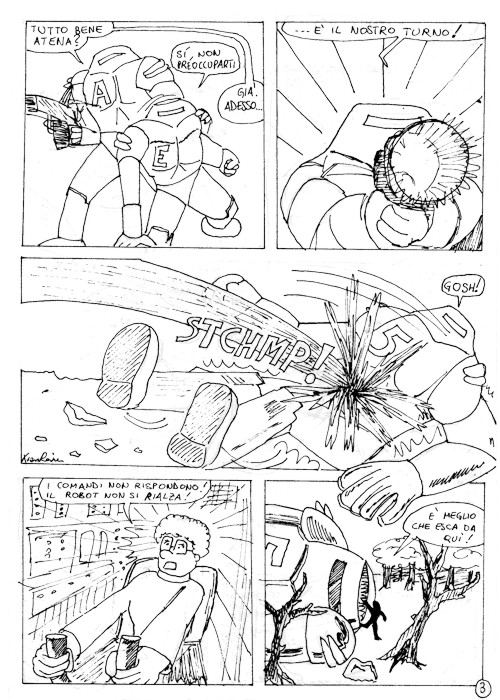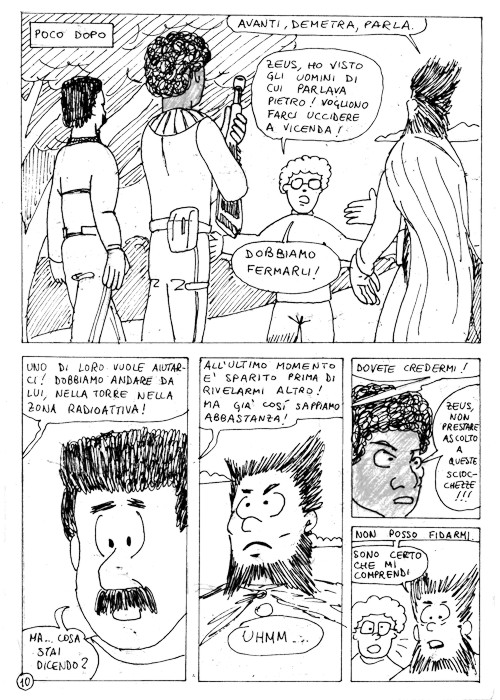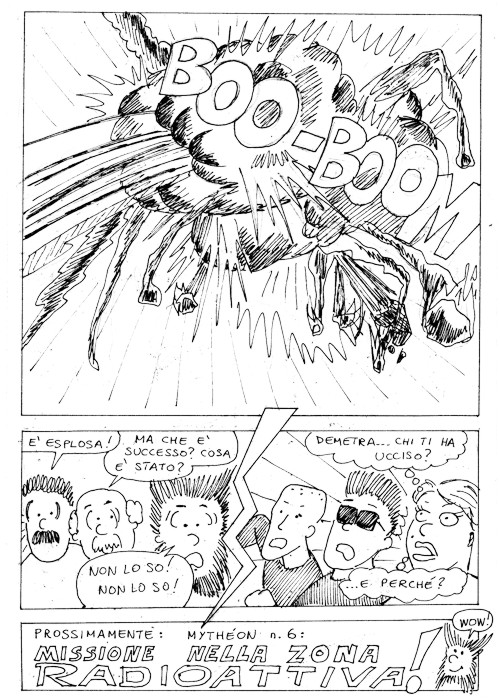I Furori del Vecchio Bodendruker
Ma non era né un orchetto né un brigante, il dottor Eriprando Maria Zeppo Von Basedoff: decenni di malaria e sifilide, e un rigido regime di alcool e sostanze psicotrope avevano temprato il suo fisico, rendendolo capace di reagire a prescindere dalle condizioni del suo cervello (generalmente pietose). In realtà la gamma di azioni di cui era capace in queste situazioni d’emergenza non era poi così ampia: consisteva principalmente nell’antica tecnica dell’opossum (cadere a terra fulminato e fingere nulla), cosa che fece anche ora, mentre i tre avventurieri proseguivano la loro discussione. Così, mezzo rintronato dall’incantesimo, e mezzo rintronato di suo, rimase immobile ad ascoltare i tre.
«Insomma, ragazzi», stava dicendo il nano, «Io proprio non vi capisco. Dov’è il vostro spirito d’avventura? Voglio dire, allora perchè siamo qui?»
«Per ammazzare mostri e saccheggiare tesori.», disse Fetedhras.
«Appunto! E allora perchè non volete andare fino alla Città Perduta?»
«Beh, Baroz,» disse Salnighiel, «Ammazzare Ukhurra e intascare l’eredità è sicuramente più semplice, no?»
«Chi è Ukhurra?», chiese Fetedhras.
«Ukhurra è la nonna del generale. La vecchia.»
«…»
«La cobolda!»
«Ok, ci sono. Ho capito.»
«E poi, Baroz,» proseguì Salnighiel, «tecnicamente anche la vecchia è un mostro. È un coboldo. Non l’hai letto il Monster Manual? Quindi siamo a posto: ammazziamo mostri e rubiamo tesori.»
«Vabbè, e il vecchio, allora? Non è un coboldo.»
«Si, ma non fa parte del nostro gruppo. La sai la regola: se non fa parte del gruppo, giù mazzate – è la prima regola dell’avventuriero.»
«E poi non è mica detto che non sia un mostro,» aggiunse Fetedhras. «Potrebbe essere un mutaforma.»
«Un Doppelganger.»
«Un Mimic.»
«Una Malfera.»
«Un Vampiro.»
«Un Bhut.»
«Un Baldandar.»
«Un drago d’oro…»
«Grazie, ragazzi, credo di aver afferrato il concetto.»
«È scappato.»
«Cosa?»
«Non cosa, chi. Il vecchio. È scappato.» Fetedhras indicò il punto dove, fino a pochi istanti prima, giaceva esanime il dottore.
Von Basedoff correva a perdifiato nella foresta, la quale era, almeno per lui, folta, oscura e pericolosa, come aveva sempre creduto che una foresta tropicale dovesse essere, specie di notte. Non aveva idea di quale direzione avesse intrapreso, né di dove lo avrebbe condotto la sua folle corsa – nella fattispecie, in una buca: un’escavazione profonda un metro e mezzo, con parecchi pali ormai marciti piantati nel fondo, e così vasta che un rinoceronte avrebbe potuto trovarvi comodamente posto.
Stava ancora bestemmiando, quando la canna di un fucile venne puntata contro di lui dall’alto. Attaccato alla canna del fucile c’era il taciturno signor Dinz.
«Buonasera, dottore.»
«Ehilà… ehm, non è come pensa… voglio dire… mi ero solo allontanato a debita distanza, sa com’è, per rispetto dell’intimità. Dei vostri compagni, intendo. Non volevo origliare.»
«Capisco,» disse Dinz, portandosi un fischietto alla bocca.
Stava per lanciare il suo richiamo, quando quello stesso rombo metallico, che già avevano udito alcune ore prima, ruppe bruscamente il silenzio che regnava nella foresta.
Dinz trasalì, e il dottore fece altrettanto.
«Che bestia sarà questa?» chiese quest’ultimo. «Ecco la seconda volta che udiamo questo suono. Si direbbe emesso da qualche strumento. Che quell’animale ci abbia seguiti?»
«Non è di certo un animale,» rispose Dinz.
Come per dargli una pronta smentita, in quel momento stesso echeggiò invece a breve distanza un formidabile barrito, anzi, un vero e proprio concerto, che si ripercosse lungamente sotto le piante.
Dinz saltò nella fossa con uno squittìo e, fosse per caso o per progetto, lasciò sfuggire la carica del suo fucile. Vedendo il lampo e udendo lo sparo, il dottore mandò un grido: credeva che si fosse ferito.
«Maledizione!» grugnì il ramingo.
«Colpito?»
«Colpito cosa?»
«Che ne so, io? Ha sparato. Pensavo sapesse quello che faceva. Secondo lei cos’è, un elefante?»
Una sorda bestemmia sfuggì alle labbra dell’altro.
«Beh, suvvia, è buona selvaggina,» disse il dottore, un po’ sorpreso.
«Non è un semplice elefante,» rispose Dinz con dispetto. «è molto peggio.»
«Non ho paura io.», mentì il dottore.
«È un Bodendruker, signore, e quei mostruosi pachidermi sono cattivi e non si arrestano dinanzi ai colpi di carabina. E neanche ai colpi di cannone, se è per questo. Lasciatelo andare, se compare.»
«Guardi, non sono venuto qui per cacciare e neanche per veder passare la selvaggina. Se lo vedo accostarsi farò l’opossum, checchè possa accadere.»
«Bravo,» disse Ullogh ruvidamente.
«Non sono mica un cacciatore novellino.»
«E poi gli elefanti appartengono al re.»
«Che c’entra il re? Ah! Eccolo!… Lo vede? Che splendido… che pachiderma… che… ma che cazzo è?!»
Un colossale elefante – un elefante verde – era improvvisamente comparso presso lo stagno, dietro ad un gruppo di cespugli, fra i quali forse si era tenuto nascosto fino ad allora: era alto almeno il doppio di un qualsiasi, banale elefante, ed era dotato di otto proboscidi. Si mostrava inquieto: agitava i suoi enormi orecchi e colle trombe aspirava fragorosamente l’aria. Certo fiutava l’odor della polvere.
«Miri alla giuntura della spalla,» disse il dottore, scuotendo Dinz. «Non è che a cinquanta metri, e non lo sbaglierà.»
«Ma che, scherziamo?» rispose il ramingo. «Anche se ferito gravemente – cosa di cui dubito, con questi fucili – ci caricherà e ci schiaccerà sotto i suoi larghi piedi.»
«Se ha paura, fuggiamo; io non farò certo la spia coi suoi amici.»
«Se ci vede, ci inseguirà.»
«E allora cosa facciamo? Stiamo qui fino a domani?»
Il dottore alzò con precauzione la testa, appoggiando il naso sul margine della buca, per meglio osservare.
L’elefante non si era mosso. La sua enorme massa spiccava nettamente presso lo stagno e si presentava di fronte. Continuava a dare segni di agitazione alzando ed abbassando le proboscidi, e pestava il suolo colle enormi zampacce, facendo schizzare in aria larghi spruzzi di fango e lasciando dietrò di sé una superficie perfettamente livellata.
Dinz non aveva nemmeno alzato la sua carabina, anzi pareva che non si occupasse in quel momento né del compagno, né del pericoloso animale.
«Senta un po’…», iniziò il dottore, toccandogli la spalla.
Un lampo illuminò la buca, seguito da una fragorosa detonazione e da una pioggia di pigne e rami secchi. Dinz aveva fatto fuoco. L’elefante, per nulla intimorito, fece due o tre passi indietro, mandando un lungo barrito, e prese la rincorsa.
«Oh cazzo!» gridò imprudentemente il dottore. «Ci ha sgamati!»
Aveva appena finito la frase, che vide l’enorme pachiderma scagliarsi verso la buca con un slancio irresistibile. Il grido del dottore l’aveva avvertito della presenza dei suoi nemici: e caricava all’impazzata, barrendo spaventosamente e colle proboscidi alte, pronto a colpire. Il ramingo, con un gesto fulmineo strappò al dottore l’archibugio. Quantunque non avesse molta fiducia in quella pessima arma arrugginita, si preparò a servirsene. L’armò rapidamente e, vedendo la bestia che stava per precipitarsi nella buca, fece fuoco a bruciapelo, quasi sotto la gola.
Il pachiderma, si arrestò di colpo, impennandosi; poi, con un’espressione perplessa, fece un lento voltafaccia. I due, altrettanto perplessi, videro l’ascia di Baroz conficcata nelle natiche verdi del mostro. Dalla macchia sentirono le grida di battaglia dei loro compagni.
«Un Bodendruker! Questi sono punti!»
«È la volta che passo di livello!»
«Dàgli al bestio!»
Dinz aveva mandato un grido di trionfo, vedendo i suoi compagni accorrere.
«Svelto!» gridò. «Fuggiamo! Ritornerà alla carica.»
«Fuggire!… E dove?»
«Sull’albero!»
«Sono vecchio! E stanco! Non posso arrampicarmi.»
«Beh, in tal caso la saluto.»
«D’altra parte un po’ d’esercizio non può che farmi bene.»
Il mostro, reso furibondo e pazzo dal dolore prodottogli da asce, lance, spade, balestre, dardi incantati, fulmini magici e persino un tridente, si era precipitato in mezzo al trio di avventurieri, barrendo come un coro di indemoniati. I due cacciatori intanto erano già balzati fuori dalla buca e si erano slanciati verso il tamarrindo, il cui tronco, coperto da piante parassite, permetteva una rapida scalata.
«Sveltosveltosveltosveltosvelto!,» gridava Von Basedoff.
Dinz si era già afferrato alle piante parassite e saliva precipitosamente, temendo che la creatura giungesse in tempo per afferrarlo. Il dottore lo aveva già abbondantemente superato: non ritenendosi sicuri sui primi rami, passarono su altri più elevati, tenendosi bene stretti.
Il pachiderma, come Dinz aveva preveduto, passato il primo momento di terrore causatogli da quella fucilata che si era veduto sparare quasi sotto la gola, e dopo aver spiaccicato e scaraventato a destra e a manca il resto del gruppo, tornava nuovamente alla carica. Era in preda ad uno spaventevole accesso di furore. I suoi barriti rimbombavano nella foresta come scoppi di artiglierie e il suo groviglio di trombe sferzava con impeto formidabile le piante e le canne, abbattendole come se fossero fuscelli di paglia. Rovinò addosso al tamarrindo con tale violenza che la pianta, quantunque fosse grossissima, oscillò violentemente, crepitando come se fosse lì lì per essere schiantata. Fu un vero miracolo se Dinz ed Eriprando non furono scaraventati al suolo.
«La sradica!» gridò il dottore, iniziando a pregare.
«Non temete,» rispose l’altro. «I tamarrindi sono elastici, ma d’una solidità eccezionale.»
Il colosso, visto che la pianta non era caduta sotto quel poderoso urto, alzò le trombe e le introdusse come tentacoli fra i rami, sperando di poter afferrare i due cacciatori e di strapparli dal loro rifugio. Poi, vista l’inutiedit&post=1058&message=1mise a rompere con furore i rami più bassi, imprimendo alla pianta nuove e violentissime scosse, per resistere alle quali il ramingo e il dottore erano costretti a tenersi abbracciati al tronco.
«Se ci lascia un momento in pace, ricominci a sparare,» disse il dottore. «Possibile che non si calmi un momento? Che cosa ne dice, eh?»
Dinz non rispose. Non era il Bodendruker che in quel momento lo preoccupava. Per la seconda volta ascoltava attentamente, borbottando fra i denti.
Intanto il mostro, sempre più inferocito, raddoppiava i suoi sforzi, impedendo a Dinz di ricaricare la carabina, giacché doveva tenersi ben stretto al tronco per non venire sbalzato a terra. Il furibondo pachiderma, dopo aver strappato tutti i rami che erano a portata delle sue proboscidi, aveva ricominciato a investire la pianta.
La sua enorme testa, pari ad un ariete, cozzava contro il tronco, mentre le sue larghe zanne strappavano lembi di corteccia e si sprofondavano nel legno. Vi era da temere che, continuando a quel modo, finisse veramente per atterrare l’albero.
«Dinz!» gridò il dottore. «Cerchi di caricare la carabina!»
«È impossibile,» rispose quegli, che cominciava a diventare inquieto. «Se lascio il tronco, cado.»
«Non si stancherà mai?»
«Ci metterei un bel no.»
«E finirà per buttare giù il tamarindo, se non riusciamo a finirlo.»
«È quello che avverrà.»
«Ah!… Maledetta bestia!…»
Uno scricchiolio sinistro si era fatto udire, dopo un urto più violento degli altri. Il dottore aveva mandato un grido, mentre Dinz si era lasciata sfuggire una rauca imprecazione. A un tratto gli urti cessarono. L’elefante doveva aver compreso che con una carica furiosa poteva riuscire a sradicare la pianta. Ma doveva anche aver udito il sinistro rumore che si stava facendo strada tra gli alberi. Un frastuono inverosimile, un rombo come di una motonave a vapore, si avvicinava rapidamente. Dalla cima del tamarrindo i due videro gli alberi della giungla piegarsi e scuotersi come fuscelli. Il Bodendruker indirizzò ai due un ultimo sguardo colmo d’odio e si allontanò rapidamente.
«E adesso? Cos’è questo rumore? Cosa succede?», gridò il dottore.
«Non lo so!» gridò Dinz, con accento di terrore. «Ma qualunque cosa sia si prepara ad investirci!»
Il ramingo stava approfittando di quel momento di sosta. Introdusse rapidamente una cartuccia nella carabina e abbassò l’arma.
Ma dalla macchia emerse, rombando e sferragliando, un marchingegno infernale: un cubo di pietra montato su ruote, una specie di casetta semovente, si fece largo tra gli alberi, accompagnata da una densa nube nera; qualunque cosa fosse, stava puntando decisamente su di loro. I due rimasero allibiti.
Dinz fece fuoco, credendo di arrestarlo in piena volata, ma la nube di fumo non s’era ancora diradata. Si udì uno schianto terribile. Non ebbe il tempo di riafferrarsi ai rami e si sentì proiettato in aria. Girò due o tre volte su se stesso, poi piombò in mezzo ai fasci di bambù che si trovavano a breve distanza e che si piegarono scrosciando sotto il peso del suo corpo. Gli parve di udire confusamente delle grida, risate, pernacchie, petardi e colpi di fucile; poi la sua mente volò via e i suoi occhi più non videro.
«Ebbene, come state, signor Baroz?»
Il nano, udendo la voce gracchiante di Ukhurra, riaperse gli occhi, guardandosi intorno con vivo stupore.
Si trovava nella sua tenda, coricato sopra un soffice cuscino di seta rossa, e l’indescrivibile nonna del generale gli stava accanto, porgendogli, sorridente, una tazza colma di un liquido fumante e odoroso.
«Una buona sorsata di brodo di piccione, signor Baroz. Ve l’ho preparato io e vi assicuro che vi farà bene.»
Il nano si alzò a sedere, continuando a guardare la cobolda e la tenda. Non riusciva a raccapezzarsi.
A un tratto si rammentò del Bodendruker e del combattimento in mezzo alla giungla.
«Come mai sono qui?» chiese. «E il mostro?… Ed il dottore?… Mi sembra impossibile di trovarmi ancora vivo. Che cosa è successo?»
«Molte cose, signor nano, ma prima bevete questo brodo,» intimò la vecchia.
«Come state?», proseguì «Vi ho esaminato e non ho trovato gravi ferite sul vostro corpo, quantunque quel marchingegno vi sia quasi passato sopra.»
«Marchingegno!… Quale marchingegno?» chiese il nano, la cui sorpresa aumentava. «Volete dire il Bodendruker?»
«Era già morto, signor Baroz,» disse Vronch, entrando nella tenda, «Il Juggernaut gli è passato sopra. Non sentite questo profumo? È un pezzo della sua tromba che cuoce. Siete ancora debole?»
«Ah!… Generale!» esclamò Baroz, stringendo la mano che gli veniva tesa. «Spiegatemi che cosa è avvenuto dopo l’assalto. Mi ricordo vagamente d’aver udito uno scroscio e veduto l’albero rovinare, e poi… che cosa è successo poi? Chi mi ha portato qui?»
«Sono avvenute delle cose molto gravi e per me assolutamente inesplicabili. Non che sia la prima volta. Ma rispondete ad alcune mie domande. Come vi sentite?»
«Ma che domanda è? Mi è passato sopra un elefante. Ho le membra un po’ ammaccate, ma nulla di più. E gli altri?»
«Se la sono cavata,» rispose Vronch. «Tranne il dottore.»
«Oh, beh, per quel che mi importa. L’elefante l’ha stritolato?»
«Non ne ha avuto il tempo. Il Juggernaut gli è passato sopra. Al Bodendruker. E poi si è portato via il dottore.»
«Non ho capito.»
«È vero, », interloquì Ukhurra. «voi ignorate come si siano svolti i fatti, giacchè quando noi vi abbiamo raccolto eravate svenuto.»
«Spiegatevi, signora,» disse il nano, che cadeva di sorpresa in sorpresa, forse anche per colpa del brodo di piccione.
«Noi avevamo udito i vostri spari. Ma prima di questi ci aveva impressionato l’udir echeggiare nella direzione da voi presa quella misteriosa nota. Non mi sembrava naturale che dovesse ripetersi ad una così notevole distanza, avendola noi udita per la prima volta a venti o venticinque miglia da qui. Non so perché, mi venne il sospetto che fosse invece qualche veicolo, che si muoveva veloce, e decisi di venire a cercarvi con Fang. Anche perchè, » e lanciò uno sguardo velenoso al nipote, «nessun altro voleva venire. Eravamo a mezza via, quando ci giunsero agli orecchi i primi spari. Affrettammo il passo e giungemmo alla sorgente nel momento in cui l’albero veniva sradicato e voi cadevate fra le canne, salutato da una scarica di fucilate. Vedemmo subito il Juggernaut, e sette od otto omini, forse nani, slanciarsi verso i bambù, armati di coltellacci. Chi fossero, non ve lo saprei dire, perché l’oscurità era troppo profonda in quel luogo. Compresi però che ce l’avevano con voi. Scaricammo senza indugio le nostre armi contro quei banditi e li mettemmo in fuga. Qualcuno era caduto, e fu subito raccolto dai compagni e portato via. Salirono sul loro coso e se la diedero a gambe.»
«Erano Nani, dite?»
«Non lo so: dei briganti forse, quantunque io abbia il sospetto che si tratti di qualcosa di più grave. Senta, parliamoci chiaro, non trovate qualche relazione fra la scomparsa del balòn e questo nuovo attentato?»
«Sì,» rispose il nano. «Vi sono ormai troppi indizi per poter dubitare. Qualcuno cerca di sopprimerci, e questo secondo agguato ne è la prova; ma a quale scopo? Io non ho mai avuto nemici a Kuglurg. Nemici vivi, intendo.»
«Potremmo tuttavia ingannarci nei nostri sospetti,» disse Vronch, dopo un breve silenzio.
«Forse,» rispose il nano, il quale era tuttavia diventato pensieroso. «Ma magari anche no.»
«Signor Baroz,» disse la vecchia, «Siete stato impavido ed eroico. Ma state attento. Non lasciatevi sorprendere in qualche altra imboscata.»
«Non andrò più a cacciare solo, ve lo prometto. Che ritornino quei banditi, generale?»
«Non credo, dopo l’accoglienza che hanno avuto. Orsù, lasciamo che quei bricconi fuggano e andiamo ad assaggiare un pezzo di tromba d’elefante.»
«Ve la siete ben guadagnata.», disse Ukhurra, prendendogli la mano.
«E il dottore?»
«Chi?»
Condividi questa opera dell'ingegno umano!







 Cioè: come facciamo a non linkare un blog che si intitola:
Cioè: come facciamo a non linkare un blog che si intitola: